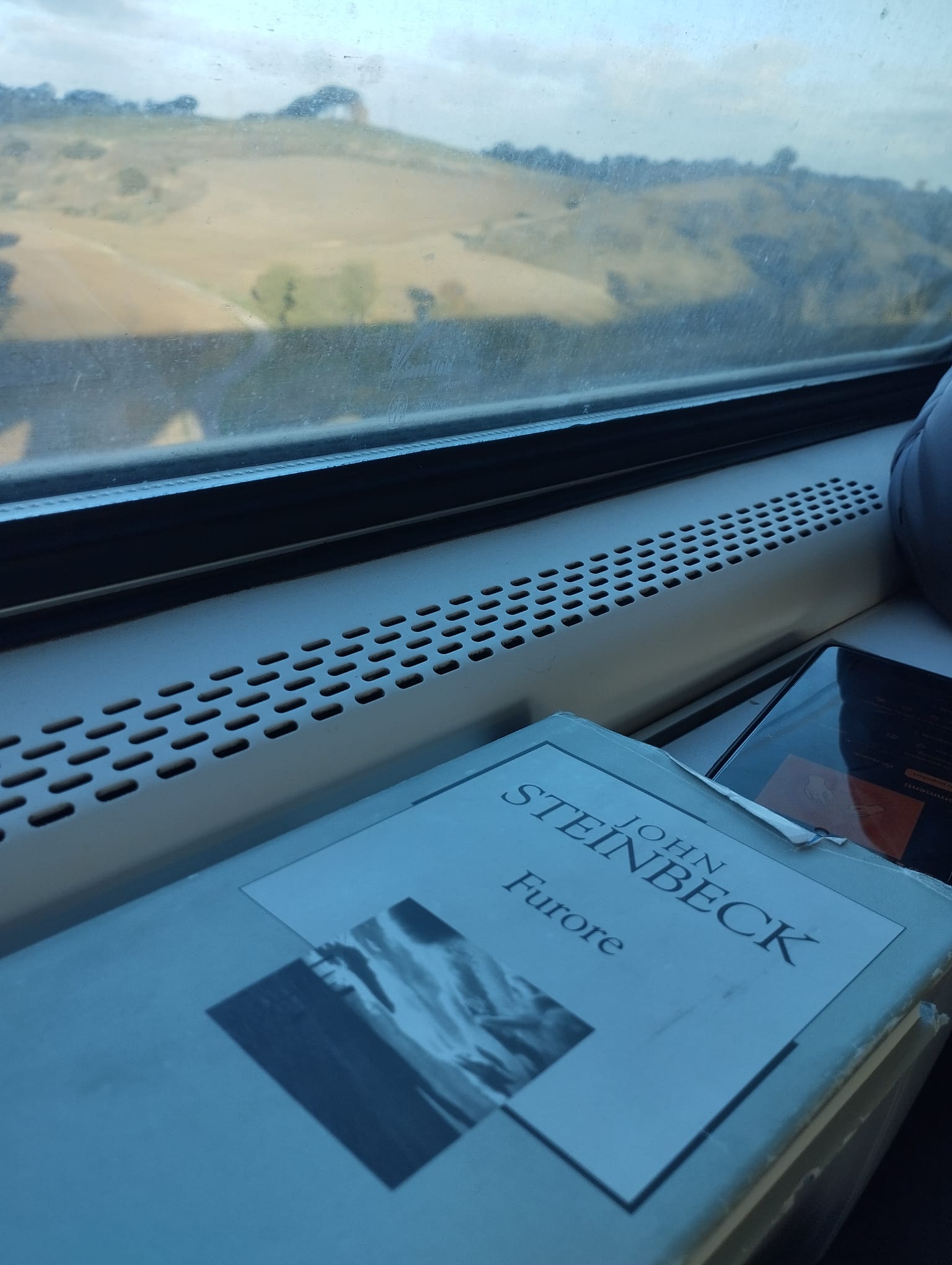
di Valerio Iannitti
In un treno delle 6.15 di improbabile lentezza, che lungo il suo tragitto ha lasciato spazio a quattro precedenze, mentre la stazione di Pomezia lasciava spazio a quegli scorci che evocano a tratti le ben più celebri dolci campagne toscane, ho terminato di leggere questo libro enorme (non mi riferisco alla mole, che pure non è trascurabile), iniziato un paio di settimane fa su tutt’altro treno, in direzione delle montagne del Nord Italia.
E questo libro parla in effetti di un viaggio, sì, ma di tutt’altro tipo.
Si svolge negli anni Trenta del Novecento, lungo il tragitto che la celeberrima Route 66 compie dall’Oklahoma verso la California, ma potrebbe svolgersi lungo molte altre rotte attuali.
Pochi decenni prima che Kerouac descrivesse i giovani in cerca di vita, Steinbeck parlava di chi era in cerca della sopravvivenza. Parlava degli ultimi tra gli americani e continua a parlare agli ultimi.
Il messaggio di Steinbeck, – diciamolo subito – è stato criticato da alcuni per essere troppo esplicito, poiché l’Autore non lascerebbe al lettore la dovuta ambiguità morale di un’opera letteraria: il bene e il male sarebbero disegnati troppo chiaramente, senza che il libro possa collocarsi al di sopra di essi (“Steinbeck predica con troppa insistenza la bontà dei poveri e la malvagità dei ricchi”, disse il critico Edmund Wilson). Ma, d’altro canto, l’ambiguità letteraria viene sacrificata per una chiarezza morale ed epica: non ci lascia dubbi su dove stia il bene, ma ci mostra la grandezza collettiva della resistenza (e direi anche della resilienza, se non fossi stato portato a detestare questo termine a causa del suo reiterato abuso), in un’epopea moderna, in cui povertà e solidarietà assumono il tono dei grandi miti fondativi. Credo che proprio questa nettezza morale, lontana da ogni compiacimento intellettuale, permetta all’Autore di raggiungere i suoi magistrali esiti, che rendono il libro una pietra miliare della letteratura americana, e non solo.
Poco dopo l’apertura leggiamo che “La polvere copriva ogni cosa, entrava nei polmoni, nei letti, nelle anime”: il riferimento è alle tempeste di sabbia che per anni, a partire dal 1930 (quindi, nel contesto della Grande Depressione), flagellano quelle zone rendendo sterili le terre, e che costituiscono l’inizio della fine. Poi c’è la meccanizzazione, che rende inutili i piccoli agricoltori. E le banche: anonime, impersonali e maligne divinità che inviano i propri emissari a cacciare i contadini.
- Sì, ma se un anno manca il raccolto, la banca deve venirci in aiuto, coi prestiti;
- Oh, ma la banca o la società non può, diamine! Non è una creatura che respira, che mangia polenta. Respira dividendi, mangia interessi. Senza dividendi, senza interessi, muore, e così morireste voi senza polenta e senz’aria. È triste, ma è proprio così (…)
Viene così a sparire il contatto con la terra, come emerge dal passaggio che segue: - E quando quel raccolto cresceva e veniva mietuto, nessun uomo aveva sbriciolato nel palmo una sola zolla, né lasciato stillare tra le dita la terra tiepida. Nessun uomo aveva toccato i semi, o agognato la crescita. Gli uomini mangiavano ciò che non avevano coltivato, non avevano legami con il loro pane. La terra partoriva sotto il ferro, e sotto il ferro a poco a poco moriva, perché non era stata amata né odiata, non aveva attratto preghiere né maledizioni.
Dentro questa cornice disumana, si muovono le vicende di migliaia di disperati che lasciano le loro terre in cerca di fortuna e, tra loro, di Tom Joad, uscito di prigione grazie alla buona condotta, e della sua famiglia. I nostri prendono la decisione più dura, si incamminano con il loro catorcio verso la California. Lo fanno trascinati da sua madre, che per tutto il libro rimane una figura centrale, che soppianta il marito ogniqualvolta c’è da prendere una decisione, e che fa di tutto per mantenere unita la famiglia, unica ragione di vita una volta che è venuto meno il contatto con la terra. Lungo il tumultuoso viaggio verso la meta, a un certo punto iniziano però a raccogliere le testimonianze di chi fa il tragitto inverso.
- “Giù da noi sono passati dei tizi che distribuivano dei volantini gialli. C’era scritto che qui cercavano un sacco di gente per la raccolta”.
- Il ragazzo rise. “Dice che in California ce n’è trecentomila come noi, e mi gioco la testa che quel maledetto volantino l’hanno visto tutti quanti.”
- “Sì, ma se non gli serve gente, perché si mettevano a stampare quella roba?”
- “Perché non provi a usare il cervello?”
È l’economia, bellezza!
Tuttavia, i Joad ci provano lo stesso, oramai hanno deciso, e appena varcato il confine della California scoprono l’odio che gli abitanti locali provano verso questi miserabili (gli okies) venuti da fuori ad elemosinare il lavoro buttando giù i salari e portando degrado. Riescono a trovare un campeggio autogestito, con tanto di lussi mai visti prima, come l’acqua calda. La polizia, a meno di necessità, non entra. La questione crea fastidio. E infatti leggiamo:
- “Be’, sabato prossimo vedete di tenere gli occhi aperti.” Timothy drizzò la schiena. Si avvicinò a Thomas. “Perché? Io faccio parte del Comitato Centrale. Lo devo sapere.” Thomas era turbato. “Non dite a nessuno che ve l’ho detto.” “Ma cosa?” incalzò Timothy. “Vedete, a quelli dell’Associazione non gli piacciono i campi del governo. I vicesceriffi non ci possono entrare. Dice che lì dentro la gente si fa le sue leggi, e non si può arrestare nessuno senza un mandato. Ecco, se scoppia una rissa e magari qualcuno spara… i vicesceriffi possono entrare e dare una bella ripulita al campo.” Timothy si era trasformato. Le sue spalle erano dritte e i suoi occhi freddi. “Che vuole dire?” “Non lo dite a nessuno” disse Thomas sempre più a disagio. “Sabato sera nel campo ci sarà una rissa. E ci saranno dei vicesceriffi pronti a intervenire.” Tom domandò: “Ma perché, Cristo santo? Quella gente non fa male a nessuno”. “Te lo dico io perché” disse Thomas. “Quelli del campo cominciano ad abituarsi a essere trattati come esseri umani. Finisce che se tornano nei campi normali non si lasciano più mettere sotto.”
Dinamiche fin troppo familiari: viene inevitabilmente in mente l’oggi, e viene da chiedersi se il nostro sistema economico e produttivo potrebbero reggere ad una società in cui tutti possano ambire a “essere trattati come essere umani”, o se la presenza di una parte di umanità ridotta a una vita indegna sia imprescindibile prerequisito per il benessere di un’altra parte della stessa umanità.
Ma andando avanti nella lettura (in uno degli “intercapitoli” con cui Steinbeck sospende il racconto della famiglia Joad, inserendo descrizioni più globali dei fenomeni in atto), emerge con chiarezza un altro degli aspetti più crudeli: il cibo lasciato marcire per non far abbassare i prezzi, al cospetto di migliaia di persone che fanno la fame, come si legge in questo noto passaggio:
- “Un delitto così abietto che trascende la comprensione. Una piaga che nessun pianto potrebbe descrivere. Un fallimento che annienta ogni nostro successo. La terra è feconda, i filari sono ordinati, i tronchi sono robusti, la frutta è matura. E i bambini affetti da pellagra devono morire perché da un’arancia non si riesce a cavare profitto. E i coroner devono scrivere sui certificati “morto per denutrizione” perché il cibo deve marcire, va costretto a marcire. Gli affamati arrivano con le reticelle per ripescare le patate buttate nel fiume, ma le guardie li ricacciano indietro; arrivano con i catorci sferraglianti per raccattare le arance al macero, ma le trovano zuppe di kerosene. Allora restano immobili a guardare le patate trascinate dalla corrente, ad ascoltare gli strilli di maiali sgozzati nei fossi e ricoperti di calce viva, a guardare le montagne di arance che si sciolgono in una poltiglia putrida; e nei loro occhi cresce il furore. Nell’anima degli affamati i semi del furore sono diventati acini, e gli acini grappoli ormai pronti per la vendemmia.”
Tra varie vicende, diversi accampamenti, sempre trascinati dalla madre di Tom, si arriva ad una piantagione di cotone. Ma arriva il momento della distruzione dovuta alle piogge…
- “Le donne osservavano i mariti, per vedere se questa volta era proprio la fine. Le donne stavano zitte e osservavano. E se scoprivano l’ira sostituire la paura nei volti dei mariti, allora sospiravano di sollievo. Non poteva ancora essere la fine. Non sarebbe mai venuta la fine finché la paura si fosse trasformata in furore. L’erba spuntò tenerissima e distese sui colli la delicata coltre verzolina dell’annata nuova”
La fuga, il deserto, la redenzione collettiva, le piogge interminabili: il racconto richiama il simbolismo biblico, rendendosi in tal modo ancora più universale. E a tale proposito, è da leggere fino alle ultimissime righe, quando appare un’immagine di solidarietà tra gli ultimi di straordinaria efficacia, che sembra voler lanciare un barlume di speranza universale in un contesto infernale.
D’altro canto, è lo stesso messaggio di universalità e speranza che sembra voler trasmettere Bruce Springsteen nella canzone che porta il nome di Tom Joad, e come Steinbeck canta la dignità degli sconfitti, per ricordarci che forse lo stato di una civiltà si misura più con la speranza che sopravvive negli ultimi, che non con il benessere dei vincenti:
(qui interpretata da Luca Marinelli, che con la sua voce e la sua interpretazione rinnova quel messaggio: https://video.corriere.it/spettacoli/radio2-social-club-luca-marinelli-canta-springsteen/c6a6b0e8-d944-4c28-afb5-e7a7585d3xlk )

